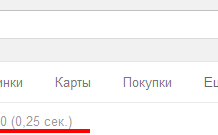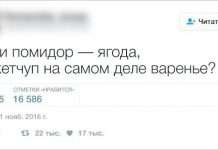Una cometa di passaggio ha affascinato l’immaginazione pubblica e acceso il dibattito tra gli scienziati: si tratta di un visitatore alieno o semplicemente di una curiosa stranezza celeste? La cometa 3I/ATLAS, scoperta dall’Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS) a luglio, ha generato un notevole buzz, alimentato in parte dalle esplicite teorie dell’astrofisico di Harvard Avi Loeb.
Anche se non c’è motivo di allarmarsi – la NASA ci assicura che non rappresenta una minaccia per la Terra – le origini e le caratteristiche della cometa hanno acceso discussioni sulla vita oltre il nostro sistema solare. L’insolito interesse del pubblico è stato amplificato quando la star dei reality TV diventata influencer di X (ex Twitter) Kim Kardashian ha chiesto informazioni direttamente su 3I/ATLAS, provocando una risposta da parte dell’amministratore ad interim della NASA Sean Duffy. Anche Joe Rogan ha dedicato segmenti del suo podcast all’argomento.
Le affermazioni di Loeb e la resistenza scientifica
Loeb, apprezzato per il suo lavoro sui buchi neri e sulla materia oscura, è diventato sempre più esplicito riguardo alla possibilità della vita extraterrestre. Negli ultimi mesi, ha suggerito che 3I/ATLAS potrebbe essere una sonda aliena tecnologicamente avanzata mascherata da cometa – un “cavallo di Troia” che spia la Terra o anche qualcosa di più sinistro.
Questa controversa teoria ha attirato una significativa attenzione da parte dei media, con Loeb che è apparso ripetutamente nei notiziari per presentare le sue argomentazioni. Sostiene che le caratteristiche insolite della cometa – il suo display insolitamente luminoso e colorato vicino al sole, il suo alto contenuto di anidride carbonica rispetto alle comete tipiche e la sua concentrazione di nichel – puntano verso origini artificiali piuttosto che processi naturali.
Loeb sottolinea inoltre che 3I/ATLAS viaggia quasi sullo stesso piano dei pianeti del nostro sistema solare, un allineamento apparentemente intenzionale che ritiene improbabile possa verificarsi in modo casuale. Egli mantiene la disponibilità a rivedere la sua posizione con ulteriori osservazioni, ma esorta i politici a considerare seriamente questa possibilità.
Tuttavia, molti scienziati contestano l’interpretazione di Loeb. David Jewitt, un astronomo dell’UCLA, afferma che tutto ciò che è stato osservato su 3I/ATLAS è in linea con il comportamento noto delle comete. Pur riconoscendo le proprietà insolite della cometa, insiste che queste possano essere spiegate da processi naturali. Esprime frustrazione per la tendenza di Loeb a inquadrare ogni osservazione come prova di artificiosità, temendo che ciò mini la fiducia del pubblico nella scienza suggerendo un insabbiamento quando vengono contestati dati anomali.
Una questione di probabilità e percezione pubblica
Il dottor Siemion di Breakthrough Listen riconosce la natura accattivante della possibilità aliena, ma sottolinea l’importanza di discutere le probabilità insieme alla speculazione. Sottolinea che mentre Loeb stima che ci sia una probabilità del “30-40%” che 3I/ATLAS sia artificiale, questa cifra manca di rigore scientifico e non è basata su dati quantificabili.
Questa mancanza di prove concrete evidenzia il divario tra la narrativa avvincente di Loeb e il consenso scientifico tradizionale. Tuttavia, Dan Fagin, direttore del programma Science, Health, and Environmental Reporting della New York University, sostiene che è utile per gli scienziati impegnarsi con l’interesse del pubblico su argomenti come la vita extraterrestre, anche quelli ritenuti non convenzionali. Sottolinea, tuttavia, la necessità di trasparenza sui limiti della conoscenza attuale e di un’attenta articolazione sia delle possibilità che delle probabilità.
La cometa 3I/ATLAS rimane un enigma cosmico, offrendo indizi allettanti sulla natura del nostro universo. Anche se probabilmente non rivelerà la presenza di alieni nelle astronavi, serve comunque a ricordare il fascino duraturo dell’umanità nel trovare la vita oltre la Terra e la sfida continua di comunicare la complessità scientifica in un’era di informazioni istantanee e teorie virali.